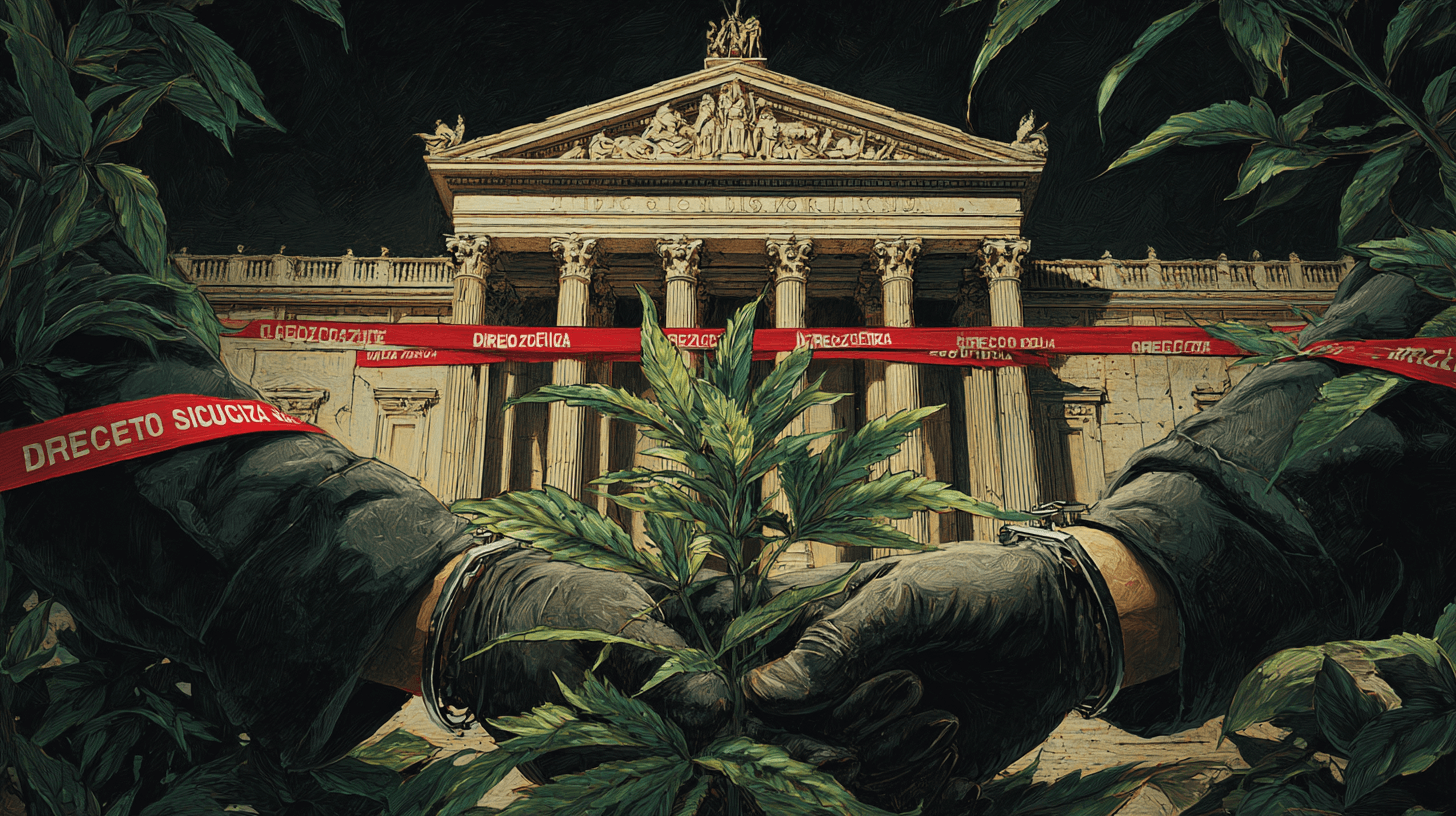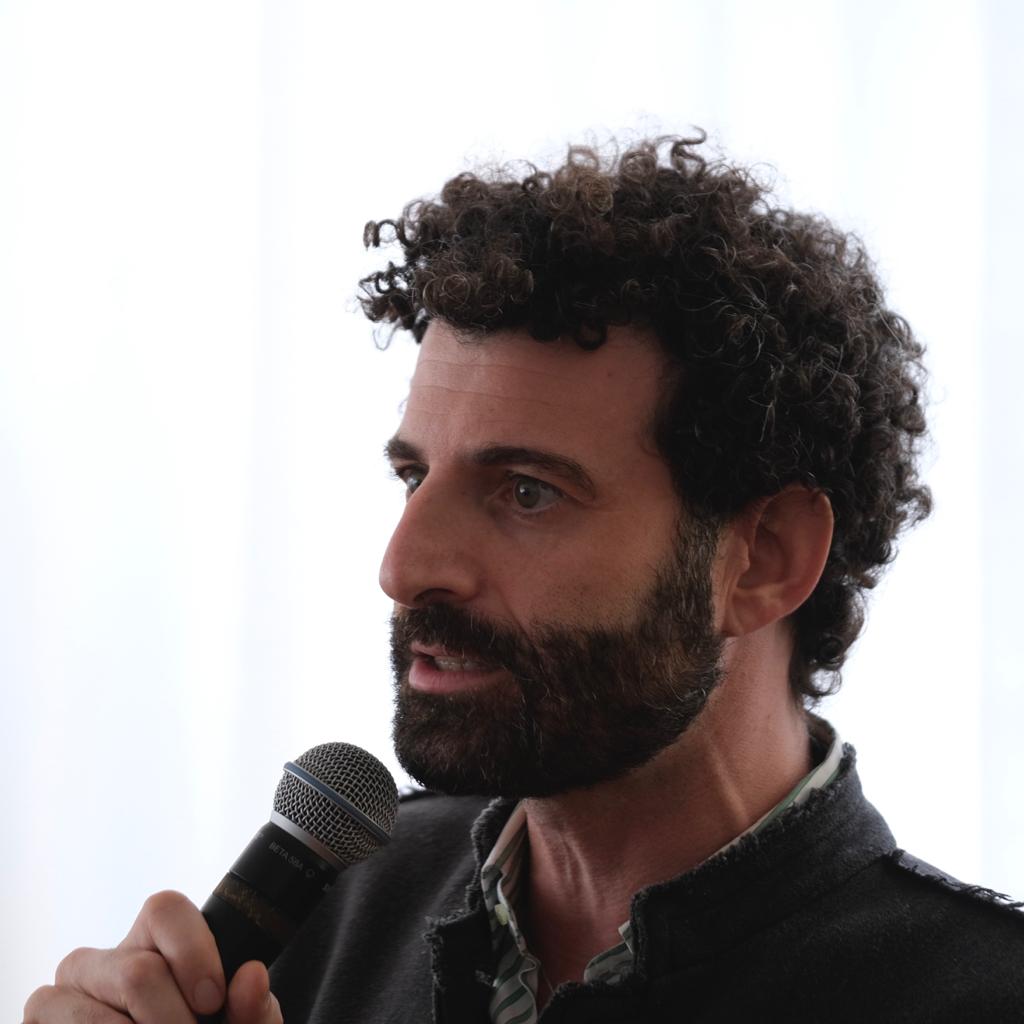
Durante gli anni sessanta e settanta la costa orientale degli Stati Uniti è stata l’epicentro della controcultura e della psichedelia come fenomeni di massa. È questa l’epoca in cui i Grateful Dead tengono indimenticabili concerti-evento segnando indelebilmente la società nordamericana nell’era moderna. Suonano per ore, lasciando ampio spazio all’improvvisazione, al cospetto di folle oceaniche giunte dai quattro angoli del Paese per vivere un’esperienza musicale, spirituale e trasformativa, più prossima ad una funzione religiosa che ad un comune live set.
Sembra incredibile come, in un contesto tanto cosmopolita, lo Stato rurale dell’Oregon sia riuscito a ritagliarsi un ruolo di protagonismo assoluto. Attratti dagli ampi spazi e dalla natura incontaminata infatti, un gran numero di artisti, musicisti e di semplici dreamers si vanno progressivamente stabilendo nella regione. Qui i Dead tennero concerti considerati epocali e, sempre qui, piccole fiere locali come la Oregon Country Fair di Eugene si tramutarono ben presto in uno dei raduni hippy più importanti in assoluto. Ma non solo: nel clima violentemente proibizionistico dell’America pre-legalizzazione, la geografia, spesso inaccessibile, di queste aree le rende ideali per la produzione illegale di stupefacenti.
Negli scantinati delle fattorie di provincia fioriscono così laboratori clandestini dove si sintetizza LSD e DMT (ancora oggi c’è chi sostiene fossero le migliori d’America), nelle umide caverne delle zone montuose si coltiva psilocibina e nelle assolate ed isolate valli del sud si pianta la marijuana.
Tanto antiche sono le tradizioni della coltivazione della cannabis in Oregon, ed è anche in virtù di questo che i genetisti locali sono universalmente considerati tra i migliori.
Sono oltre 50 anni infatti che i sapienti agricoltori locali imparano a conoscere e sfruttare al meglio le peculiari caratteristiche di questa terra, tra le più fertili al mondo, e selezionano, generazione dopo generazione, le piante migliori per forza, intensità e aroma, creando sementi sempre più perfettamente acclimatate.
Quando misi piede per la prima volta nella Rogue Valley, così chiamata per la violenza con cui le popolazioni native accolsero i primi coloni europei all’inizio dell’ottocento, ancora non sapevo che sarebbe diventata il mio “campo base” per tutti gli anni a venire, e di certo ignoravo il fatto di trovarmi nella Mecca della marijuana made in U.S.A.
La Rogue Valley sta alla cannabis come il comune di Montalcino sta al vino rosso.
Qui il clima è talmente perfetto, il suolo talmente adatto, le genetiche talmente selezionate, che la produzione locale ha una nomea senza eguali sul mercato.
In questi luoghi gli agricoltori ricavano una pletora di infiorescenze diversissime tra loro per colore, profumo, sapore, potenza e combinazione dei principi attivi. Indica, sativa o ibrida. Dal carattere più marcatamente medico o, viceversa, spudoratamente ludico: non c’è esigenza del consumatore che qui non possa essere soddisfatta.
Le colture sono rigorosamente “a terra” e outdoor (anzi sungrown, cresciute al sole, come amano definirle orgogliosamente i locali), in piantagioni organiche ed ecosostenibili al 100%. Gli unici limiti, in questo caleidoscopio del THC, sono la fantasia e la bravura del genetista nell’incrociare e migliorare le specie. Arbitro unico della competizione, il libero mercato legale.
Jagermaister /Peaches n’ Cream, Dutch Treat, White Monkey, New York Cheese /Diesel, Pineapple, Blueberry Kush, sono solo alcune delle varietà di “erba” che ho visto avvicendarsi, stagione dopo stagione, nelle weed farm dell’Oregon meridionale.
Ma ciò che lascia assolutamente stupefatto chiunque visiti la regione e si intenda un minimo della materia, non è tanto la qualità del prodotto, quanto le sue dimensioni.
Qui non si coltivano piante di marijuana: qui si coltivano alberi di marjuana.
Ne ho visti alcuni superare i 5 metri di altezza complessiva, sfiorando circonferenze di 6/7 metri, con chiome gonfie di cime della lunghezza del mio intero braccio. Su di esse infiorescenze con una densità tale da non riuscire nemmeno a separarle l’una dall’altra, composte da calici grandi come chicchi di mais.
A fine estate, e quindi a piena maturazione, questi alberi sono in grado di secernere una così grande quantità di resina biancastra e cristallina da farli baluginare al sole, dando l’impressione di stare guardando a fronde innevate in un paesaggio d’alta montagna.
Mai mi sarei immaginato potessero esistere piante di cannabis del genere prima di trovarmene una davanti.
Ognuno di questi “mostri”, avrei scoperto settimane più tardi, è in grado di produrre una forbice tra le 10 e le 15 libbre di marijuana (circa tra i 5 e i 7 chili). E mi riferisco al peso dei soli fiori, già essiccati e perfettamente trimmati (ovvero ripuliti dai rametti e dalle foglie superflue), pronti quindi per essere consegnati ai dispensari per la vendita al paziente o al cliente finale.
Qualche anno fa, durante una delle mie lunghe permanenze nella valle, affittai una stanza nella casa di un ragazzo jamaicano che da anni si era trasferito in Oregon a vivere ed a lavorare nelle piantagioni della zona. Una sera, dopo cena, stavamo fumando insieme una canna in veranda, contemplando il Rogue River scorrere placido a pochi metri da noi. La canna era rollata con cura, avvolgendo pura cannabis, finemente macinata, in una grande foglia di tabacco molto profumato, che lui si faceva spedire direttamente dalle piantagioni del suo villaggio in Jamaica. Una finezza capace di aggiungere un elemento di grande esotismo ad un momento già di per sé speciale. In quella occasione, mi ricordo, confessò apertamente che uno dei motivi per cui aveva deciso di fermarsi lassù era che nemmeno nel suo paese d’origine, considerato da chiunque la vera patria della cannabis, aveva mai visto piante così imponenti e floride.
“Qui hanno creato l’Università della marijuana”, aveva esclamato, ancora incredulo, avvolto in una nuvola di fumo denso.





_(1)_1734692176.png)